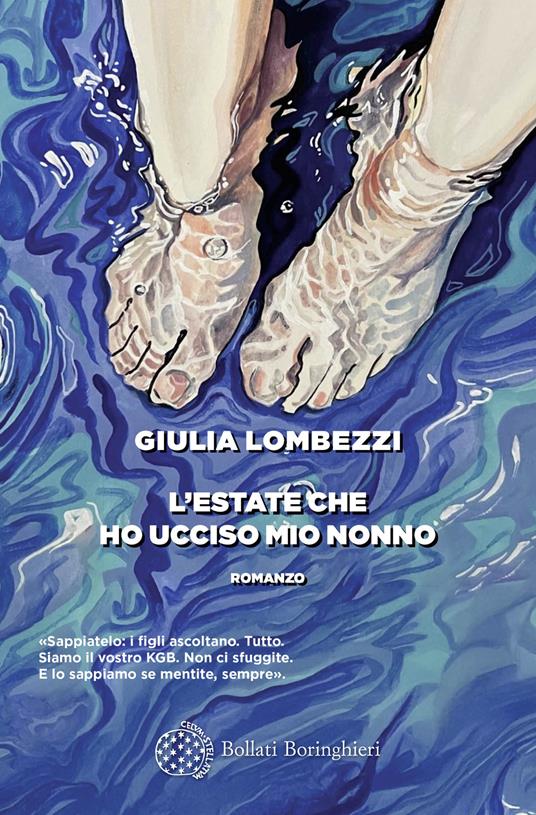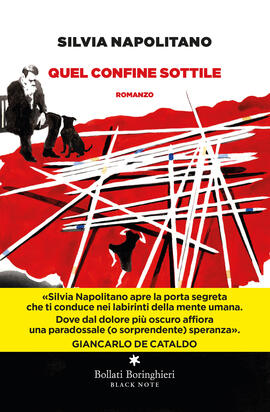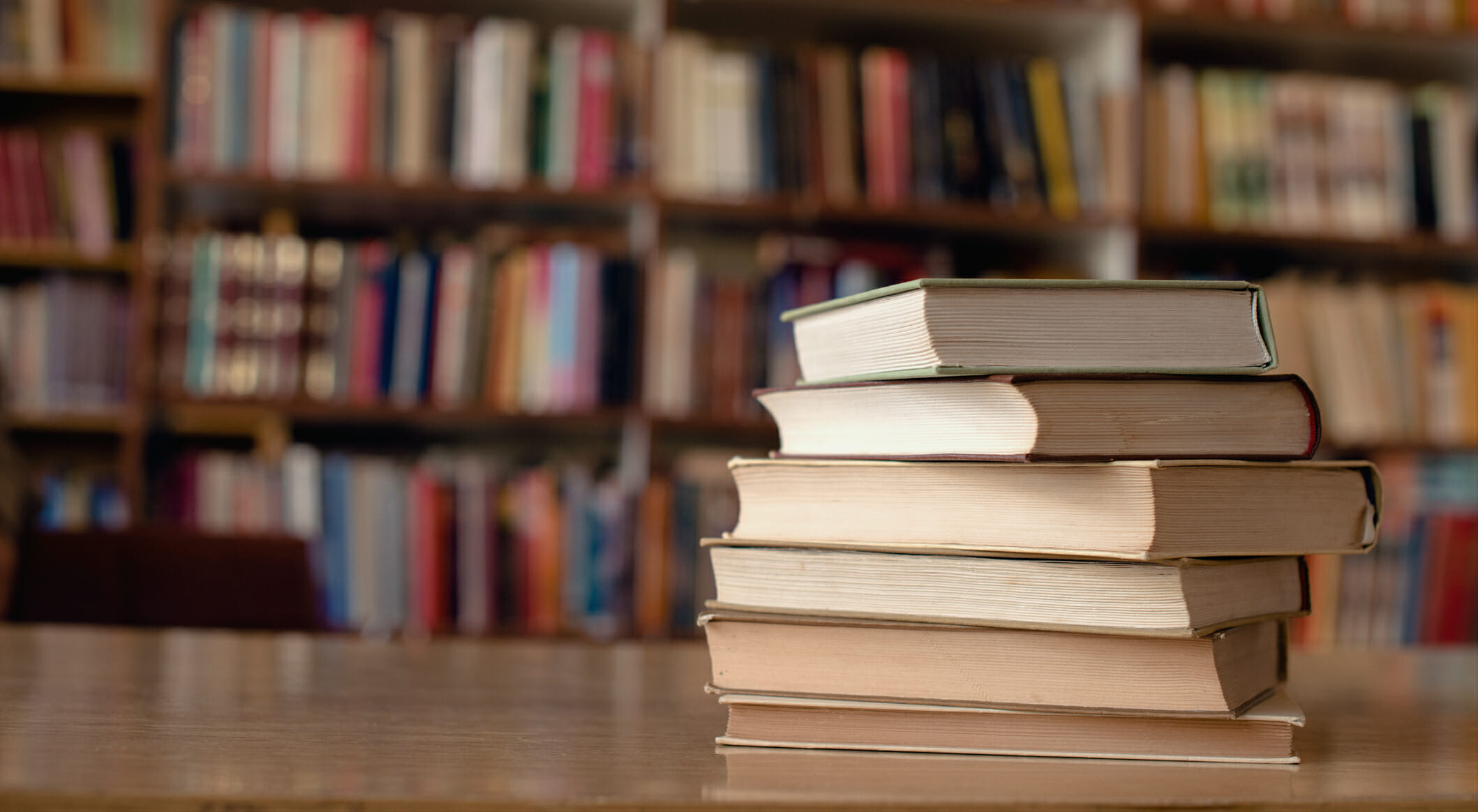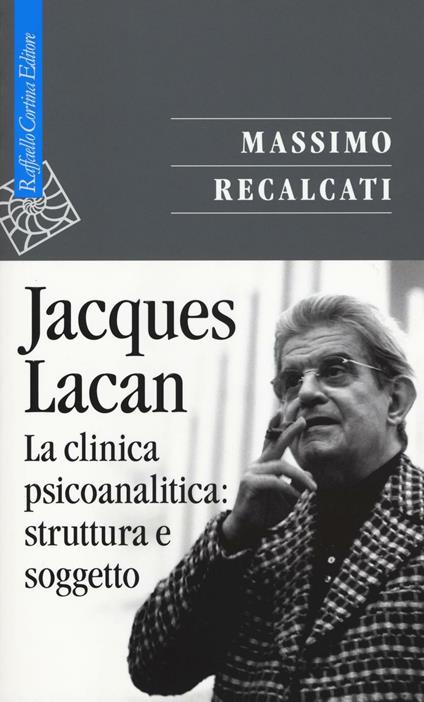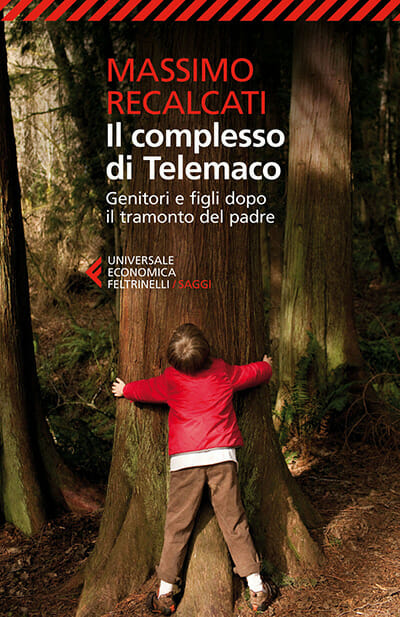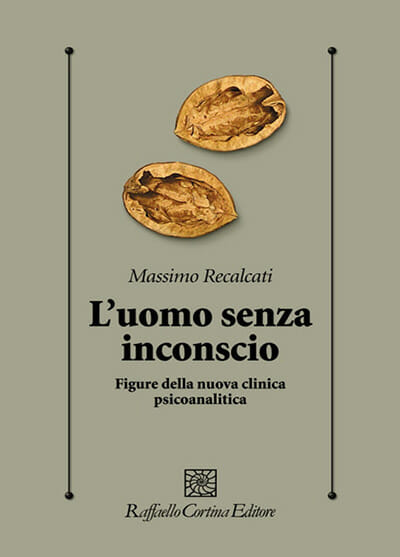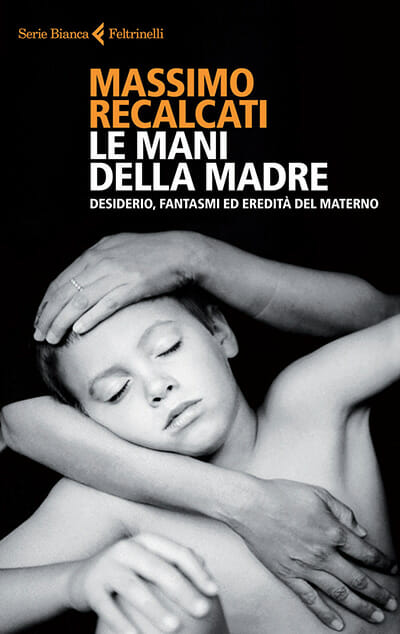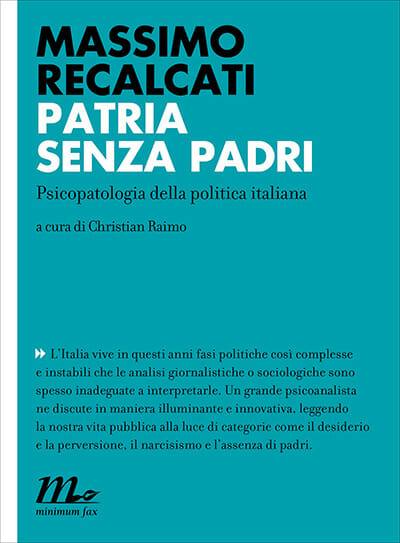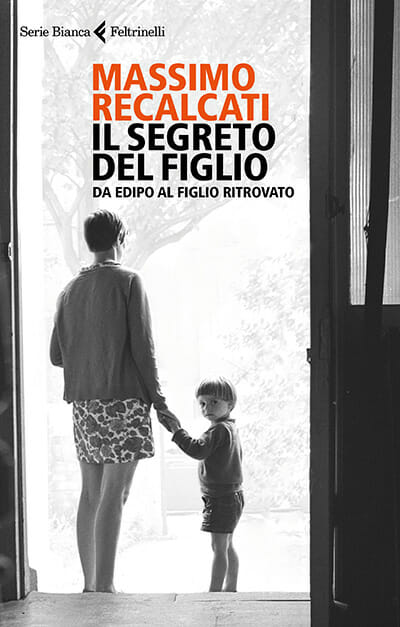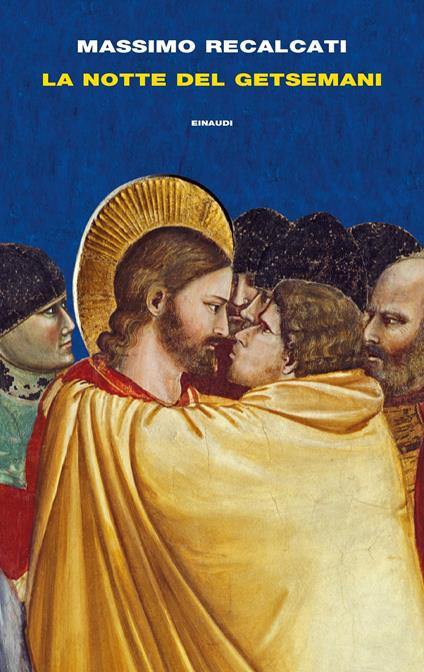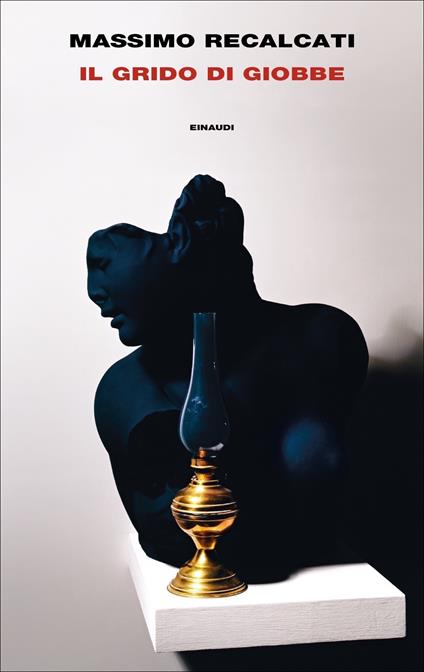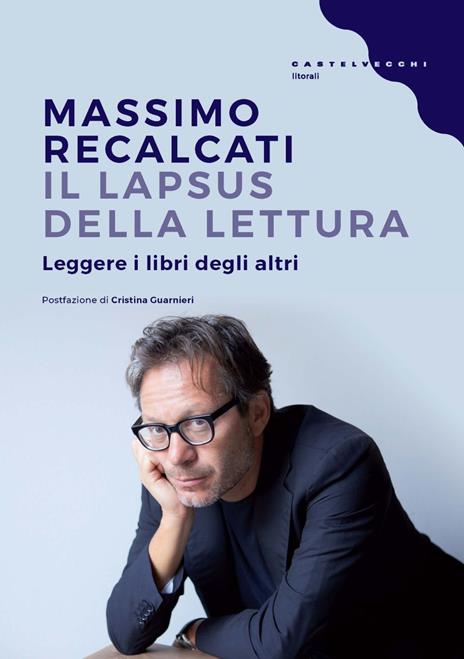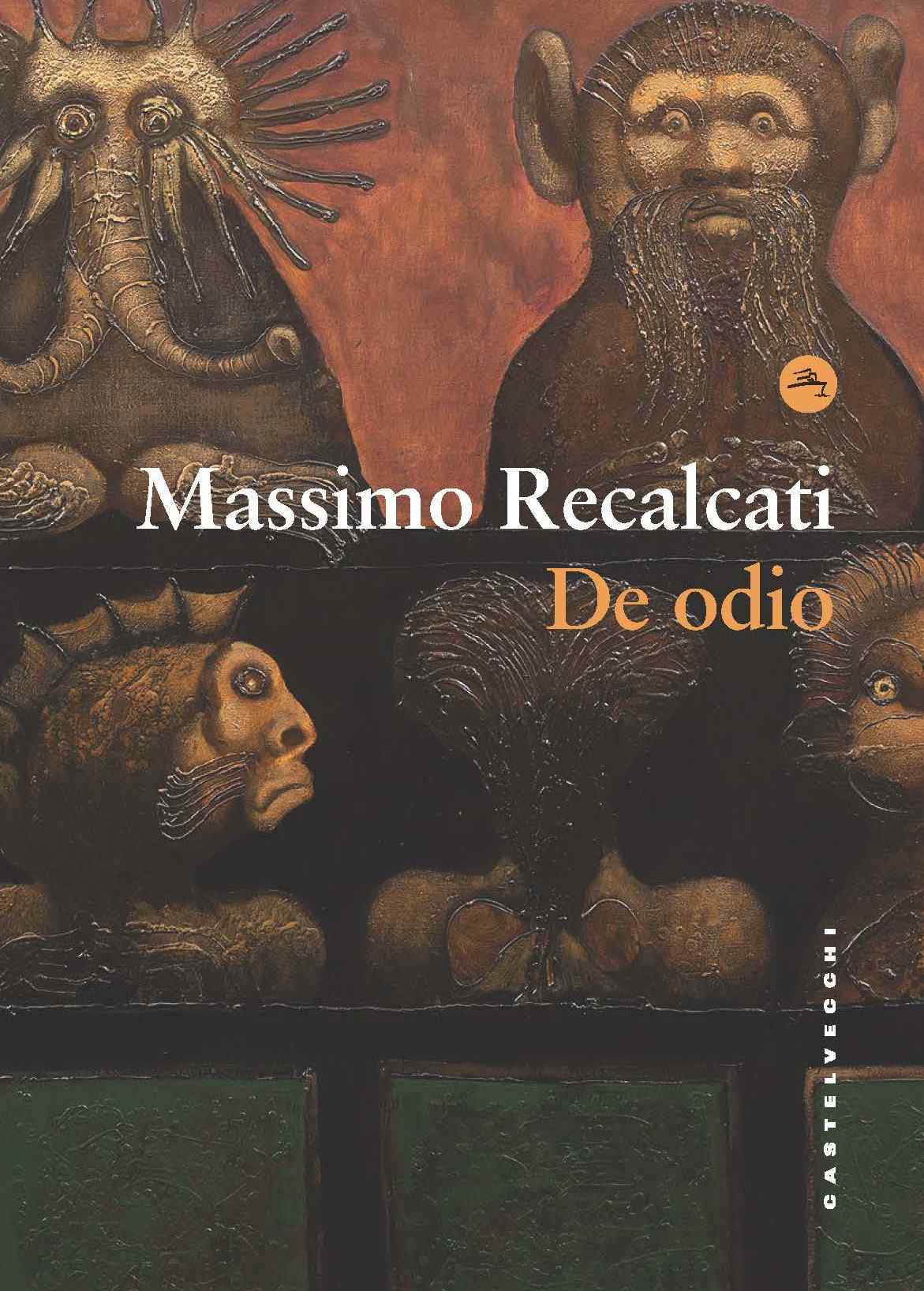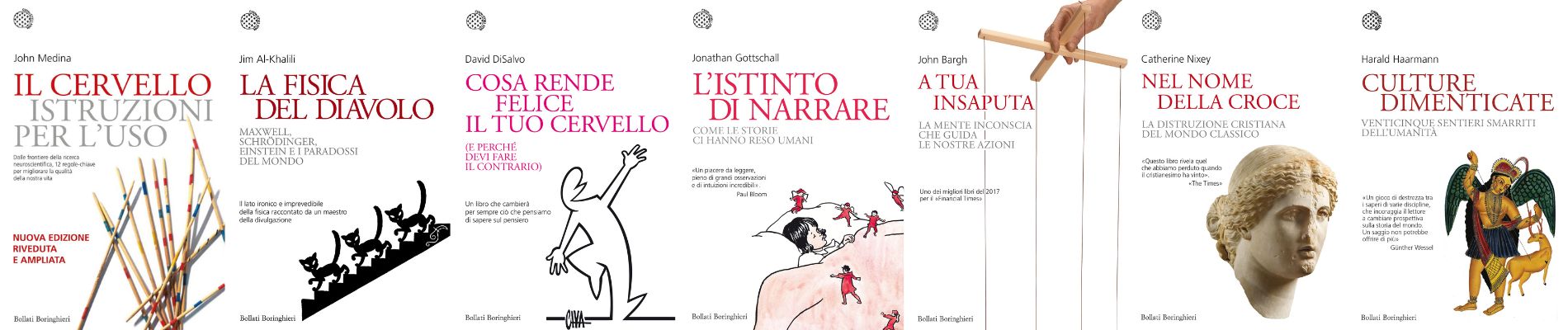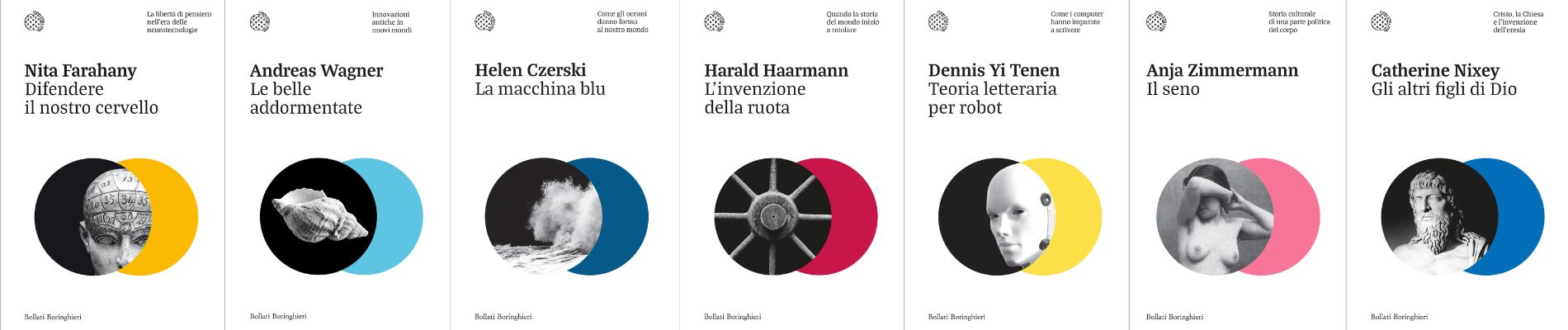Rinomato psicanalista lacaniano, saggista, direttore della Scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA, nonché professore all’Università degli Studi di Pavia e di Verona, Massimo Recalcati, classe 1959, ha concentrato i suoi studi su alcuni filoni specifici che, nel corso degli anni, ha avuto modo di approfondire nella sua vasta produzione saggistica.
Ecco quindi un percorso dedicato alle macroaree tematiche di cui si è occupato dagli anni Novanta in poi, a cominciare dalle sue prime pubblicazioni fino ai titoli più recenti che sono arrivati in libreria…
Psicopatologia ed esponenti della psicanalisi
Le prime opere di Massimo Recalcati ruotano soprattutto intorno alla psicopatologia: dai disturbi alimentari, alle dipendenze patologiche, dal panico alle depressioni e alle psicosi latenti. E a testimoniarlo sono testi quali L’ultima cena: anoressia e bulimia (Bruno Mondadori), Clinica del vuoto (FrancoAngeli) e Anoressia, bulimia e obesità (Bollati Boringhieri), quest’ultimo scritto a quattro mani con Uberto Zuccardi Merli.
Parallelamente, Recalcati si è dedicato a più riprese alla storia della psicanalisi, con saggi su alcune delle sue principali figure, come Sigmund Freud (1856-1939) e Jacques Lacan (1901-1981), occupandosi in particolare dell’esegesi del pensiero di quest’ultimo, di cui ha raccontato lo sviluppo nei volumi Il vuoto e il resto (CUEM), L’universale e il singolare (Marcos y Marcos), Jacques Lacan, un insegnamento sul sapere dell’inconscio (Bruno Mondadori, con Antonio Di Ciaccia), Jacques Lacan. Desiderio, godimento e soggettivazione (Raffaello Cortina Editore) e, più di recente, Jacques Lacan. La clinica psicoanalitica: struttura e soggetto (Raffaello Cortina Editore) e Jacques Lacan (Feltrinelli).
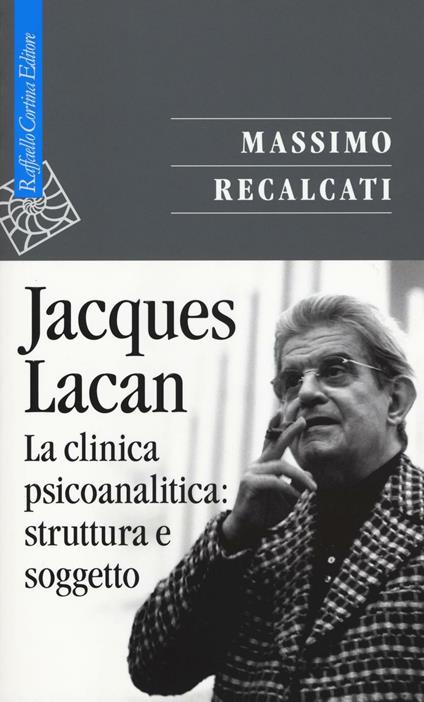
Tipico del metodo lacaniano (ma anche di quello freudiano) è il ricorso costante al mito e al simbolo, un tratto fatto proprio anche da Recalcati, che si avvale di continui richiami al cinema, alla letteratura, e a tutte quelle figure che possono essere viste come espressione e rappresentazione di un’epoca e di una società.
Massimo Recalcati e le figure familiari
Nel corso degli anni, in particolare dopo la pubblicazione di Cosa resta del padre? (Raffaello Cortina Editore), Massimo Recalcati si è poi dedicato allo studio della figura del padre e della paternità nell’epoca contemporanea, che vede caratterizzata dallo smembramento della famiglia tradizionale e dallo smarrimento del soggetto – privo di una guida, privo di una Legge e in balia del Desiderio.
Attraverso i già citati Freud e Lacan, nonché alcune esponenti della letteratura contemporanea (fra cui Philip Roth e Cormac McCarthy) e del cinema (si veda Clint Eastwood), l’autore delinea così i tratti di una paternità indebolita, ma comunque vitale, priva di ogni aura teologica e fondata sul valore etico della testimonianza singolare.
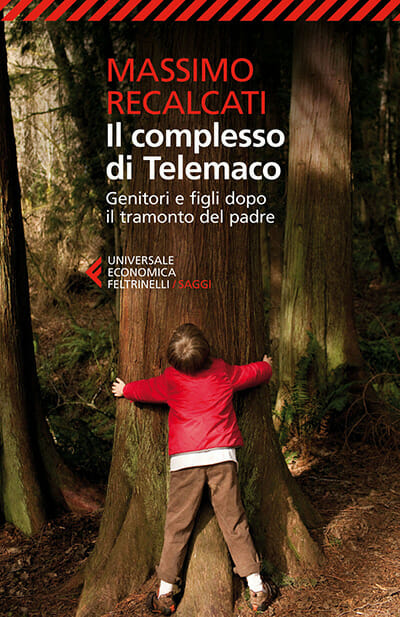
La sua ricerca sul padre e, di conseguenza, sul rapporto padre-figlio, ha condotto Recalcati a proporre l’idea di un complesso di Telemaco come rovescio del complesso di Edipo, formulata compiutamente proprio nel saggio Il complesso di Telemaco (Feltrinelli).
Se il complesso di Edipo era un concetto elaborato da Freud e raccolto da Carl Gustav Jung (1875-1961), che prendendo spunto dal mito di Edipo si riferisce all’idea che il bambino maturi attraverso un’identificazione e rivalità con il genitore del proprio sesso, collegata al desiderio nei confronti del genitore del sesso opposto, Recalcati propone l’idea che oggi il rapporto tra padri e figli sia cambiato.
Riprendendo ricerche già compiute da Lacan, suggerisce infatti che questo legame possa essere spiegato piuttosto con la figura di Telemaco, il figlio di Ulisse che attende il ritorno del padre: la figura paterna è scomparsa, è assente come l’eroe omerico, ma allo stesso tempo “nuovi segnali, sempre più insistenti, giungono dalla società civile, dal mondo della politica e della cultura, a rilanciare una inedita e pressante domanda di padre”.
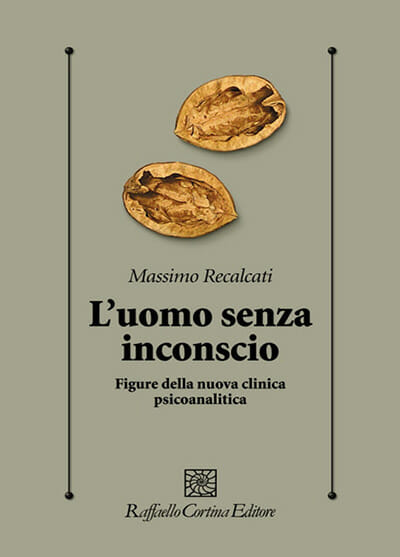
Odisseo, però, non era solo padre, ma anche re: ciò che i figli attendono dunque non è solo il ritorno della figura genitoriale maschile, ma anche quello dell’autorità e della legge. Il complesso di Telemaco, pertanto, secondo Massimo Recalcati è proprio di una società capitalista in cui l’autorità paterna e la legge si sono dissolte, in cui viene meno il processo dell’ereditarietà tra padri e figli, e in cui a questi ultimi manca una figura che sia esempio e testimonianza di come si possa vivere con slancio e vitalità.
La contemporaneità sarebbe dunque caratterizzata, secondo l’autore, da una spinta compulsiva al godimento solitario (narcisistico e cinico), che esclude lo scambio simbolico con l’Altro. Un’idea approfondita già nel saggio L’uomo senza inconscio (Raffaello Cortina Editore), per spiegare le forme più diffuse di disagio nella società odierna: anoressie, bulimie, obesità, tossicomanie, depressioni, attacchi di panico e somatizzazioni.
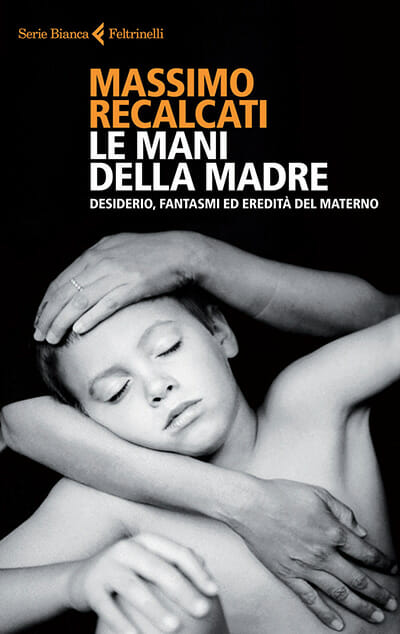
Successivamente, Recalcati ha rivolto lo sguardo anche alla figura della madre in un saggio intitolato appunto Le mani della madre (Feltrinelli), in cui ha cercato di superarne le rappresentazioni più canoniche raccontando i diversi volti della maternità, con le sue luci e le sue ombre attraverso esempi culturali e clinici.
Non esiste, sostiene al suo interno l’autore, il cosiddetto istinto materno: la madre non è la genitrice del figlio; e il padre non è il suo salvatore. La generazione non esclude per di più fantasmi di morte e di appropriazione, cannibalismo e narcisismo: perché l’amore materno non è senza ambivalenza.
In tal senso l’assenza della madre è importante quanto la sua presenza, il suo desiderio non può mai esaurire quello della donna e la sua cura resiste all’incuria assoluta del nostro tempo: la sua eredità, del resto, non è quella della Legge, ma quella del sentimento della vita. Il suo dono è quello del respiro, e il suo volto è il primo volto del mondo.
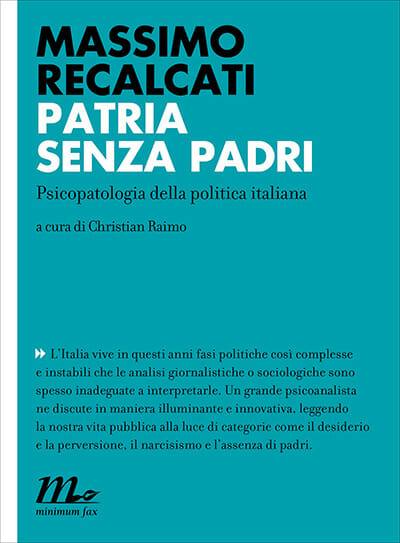
Ma anche la società nel suo insieme e nella sua dimensione politica si presta a essere analizzata con gli strumenti della psicanalisi. È quello che fa Recalcati nel saggio Patria senza padri (minimum fax), un libro-intervista in cui propone una lettura della vita politica e collettiva in Italia attraverso le categorie su cui basa da sempre il suo lavoro: il desiderio e la Legge, il rapporto con l’Altro, il narcisismo, la dinamica del conflitto…
La crisi dei partiti, la sfiducia verso le istituzioni e l’ascesa di nuovi populismi, una precarietà opprimente, il malessere diffuso, le dimissioni di un pontefice e l’attardarsi al potere di una classe dirigente incapace di crearsi degli eredi: questi sono i fenomeni che hanno creato nell’Italia degli anni Dieci una situazione di instabilità profonda, a partire dalla quale Recalcati cerca di stabilire da dove possano riprendere un dibattito e un’attività pubblica psicologicamente sani, responsabili e coraggiosi.
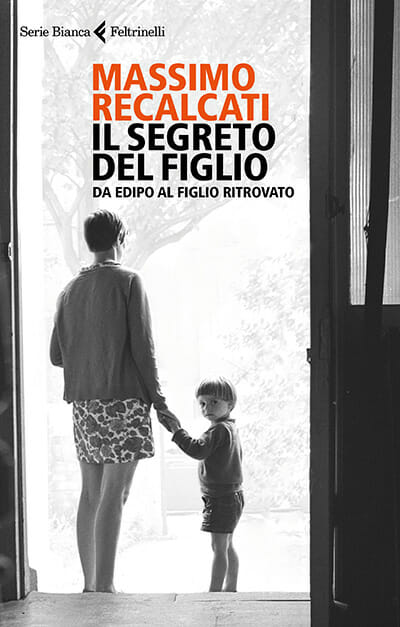
Qualche anno dopo, con Il segreto del figlio (Feltrinelli), l’autore completa poi un’ideale trilogia dedicata alla figura del padre, della madre e del figlio: “Nel tempo in cui tramonta la Legge che punisce e castiga inesorabilmente, il compito primo dei genitori – scrive Recalcati – è quello di avere fede nel segreto incomprensibile del figlio.”
Lo splendore di un figlio consiste infatti nel suo segreto, che si sottrae alla retorica dominante dell’empatia e del dialogo. Un figlio è un’esistenza unica, distinta, irriducibile a quella dei suoi genitori.
E, contro ogni autoritarismo e contro una pedagogia falsamente libertaria, Recalcati afferma il diritto del figlio a custodire il segreto della sua vita e del suo desiderio, proponendo un confronto tra due figure mitiche di figlio – quella dell’Edipo di Sofocle (497-406 a.C.) e quella del figlio ritrovato della parabola lucana –, che ci permette di osservare il suo ruolo da una nuova prospettiva.
Le figure bibliche secondo Massimo Recalcati
A partire dal 2019, Recalcati si è poi concentrato su alcuni episodi cruciali della Bibbia, con l’intento di rintracciare l’eredità più profonda del pensiero psicoanalitico e di indagare il rapporto tra le figure presenti nell’Antico e nel Nuovo Testamento e i paradigmi dei nostri giorni.
Ad aprire questo percorso è La notte del Getsemani (Einaudi), quella che Gesù trascorre nell’orto degli ulivi poco fuori Gerusalemme, a conclusione dell’Ultima Cena. Il bacio di Giuda, le lacrime di Pietro, la fuga dei discepoli, sudore e sangue, l’abbandono del padre, la preghiera: la notte del Getsemani, sostiene Recalcati, è la notte dell’uomo.
Ed è, soprattutto, lo scandalo rimproverato a Gesù: aver trascinato Dio verso l’uomo. Motivo per cui in primo piano non può che esserci l’esperienza dell’abbandono assoluto, della caduta, della prossimità irreversibile della morte e della preghiera.
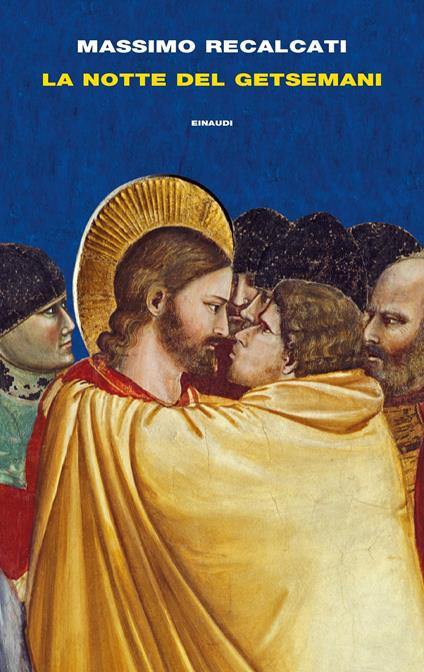
Seguono Il gesto di Caino (Einaudi), nel quale l’autore riflette sul fatto che – nella narrazione biblica – l’amore per il prossimo venga dopo l’esperienza originaria dell’odio fratricida, e Il grido di Giobbe (Einaudi), personaggio che d’un tratto si ritrova “nudo e rasato“, ricoperto di piaghe, e che cade così nella cenere.
Nel trovarsi esposto alla violenza insensata della propria sofferenza, Giobbe – che nella lingua ebraica significa “Dov’è il padre?” – rivolge a Dio una preghiera sotto forma di grido: “Perché a me? Perché l’ingiustizia di tutto questo dolore?“.
Certamente, sottolinea Recalcati, esso “non può essere ricondotto all’ordine del senso perché nessuna teologia, come nessuna altra forma di sapere, è in grado di spiegarne l’eccesso“. Il grido di Giobbe accade quindi quando le parole sono costrette al silenzio, spezzate dal trauma del male. E non tanto è indice di rassegnazione, quanto piuttosto di lotta e di resistenza.
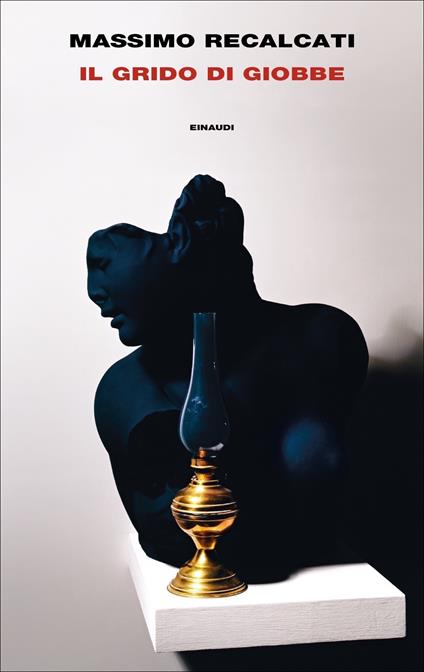
La riflessione di Recalcati si sviluppa poi in due volumi sulle radici bibliche della psicanalisi: La Legge della parola e La legge del desiderio, pubblicati entrambi da Einaudi. Nel primo, l’autore si impegna a dimostrare che non solo non c’è contrapposizione tra il logos biblico e la psicanalisi, ma che quell’antico logos ne costituisce una delle sue radici più ancestrali.
Nel secondo, invece, l’obiettivo è sfidare i luoghi comuni e gli stereotipi della lettura psicoanalitica del cristianesimo per raccontare come la testimonianza di Gesù sia innanzitutto testimonianza della vita indistruttibile del desiderio.
Un’’eredità ripresa ancora una volta dalla psicanalisi di Freud e Lacan, per i quali la Legge, attraverso il desiderio, serve la vita e non la morte. Non si tratta, in altri termini, di sottomettere la vita alla Legge, ma di vedere nella Legge – quella dell’amore e della grazia – una forza al servizio della vita: solo così la Legge non incuterà più il timore della punizione severa, liberandosi della morte per sostenere il desiderio.
Lo sguardo al mondo contemporaneo
Parallelamente, Massimo Recalcati non ha mai smesso di osservare il presente in maniera più trasversale, occupandosi di argomenti puntuali e dalla forte risonanza contemporanea attingendo a fonti ora laiche e ora religiose, ora psicanalitiche e ora di più ampio respiro, com’è accaduto con I tabù del mondo (Einaudi) e con Contro il sacrificio (Raffaello Cortina Editore) prima, e con Le nuove melanconie (Raffaello Cortina Editore), Esiste il rapporto sessuale? (Raffaello Cortina Editore) e La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia (Feltrinelli) poi.
A riscuotere un certo successo, anche tra un pubblico di non addetti ai lavori, è stato fra l’altro Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull’amore (Feltrinelli), che in sette brevi capitoli scandaglia degli interrogativi annosi e universali sul sentimento più antico del mondo, offrendo a lettori e lettrici i testi del programma televisivo Lessico amoroso.
Da non dimenticare, sempre nell’ambito della divulgazione, anche A libro aperto (Feltrinelli), in cui Recalcati parla dei dieci libri che ha amato di più, evidenziando fino a che punto le opere letterarie siano incontri d’amore in grado di far risuonare il nostro enigma più profondo, e Il lapsus della lettura (Castelvecchi), in cui una serie di meditazioni ricompongono l’autobiografia intellettuale di uno psicanalista che interroga ancora e ancora il mistero della parola.
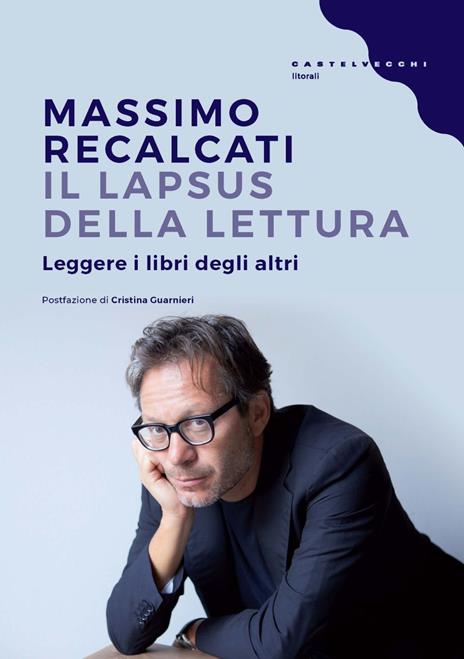
Quanto alla dimensione più sociale della produzione di Massimo Recalcati, è da segnalare La tentazione del muro (Feltrinelli), in cui l’autore usa gli strumenti teorici del proprio mestiere per soffermarsi sugli snodi fondamentali e i paradossi che caratterizzano la vita psichica degli individui, dei gruppi umani e delle istituzioni quando bisogna scegliere se vivere nel chiuso della propria identità o iscrivere la propria vita in una relazione con l’Altro.
Senza dimenticare A pugni chiusi (Feltrinelli), un ritratto psicanalitico della vita collettiva e dei problemi del mondo degli ultimi vent’anni, e il recentissimo Il vuoto e il fuoco. Per una clinica psicoanalitica delle organizzazioni (Feltrinelli). Quest’ultimo, più nello specifico, ci offre una sintesi del lavoro di Recalcati nelle organizzazioni, spiegandoci in che modo possono durare nel tempo mantenendo vivo lo slancio “misterioso e commovente”, come direbbe Pier Paolo Pasolini (1922-1975), del loro inizio, evitando di ammalarsi e di disperdere la loro potenza: un ripensamento radicale del soggetto collettivo, che ancora una volta non può prescindere dall’acuta lente della psicanalisi.
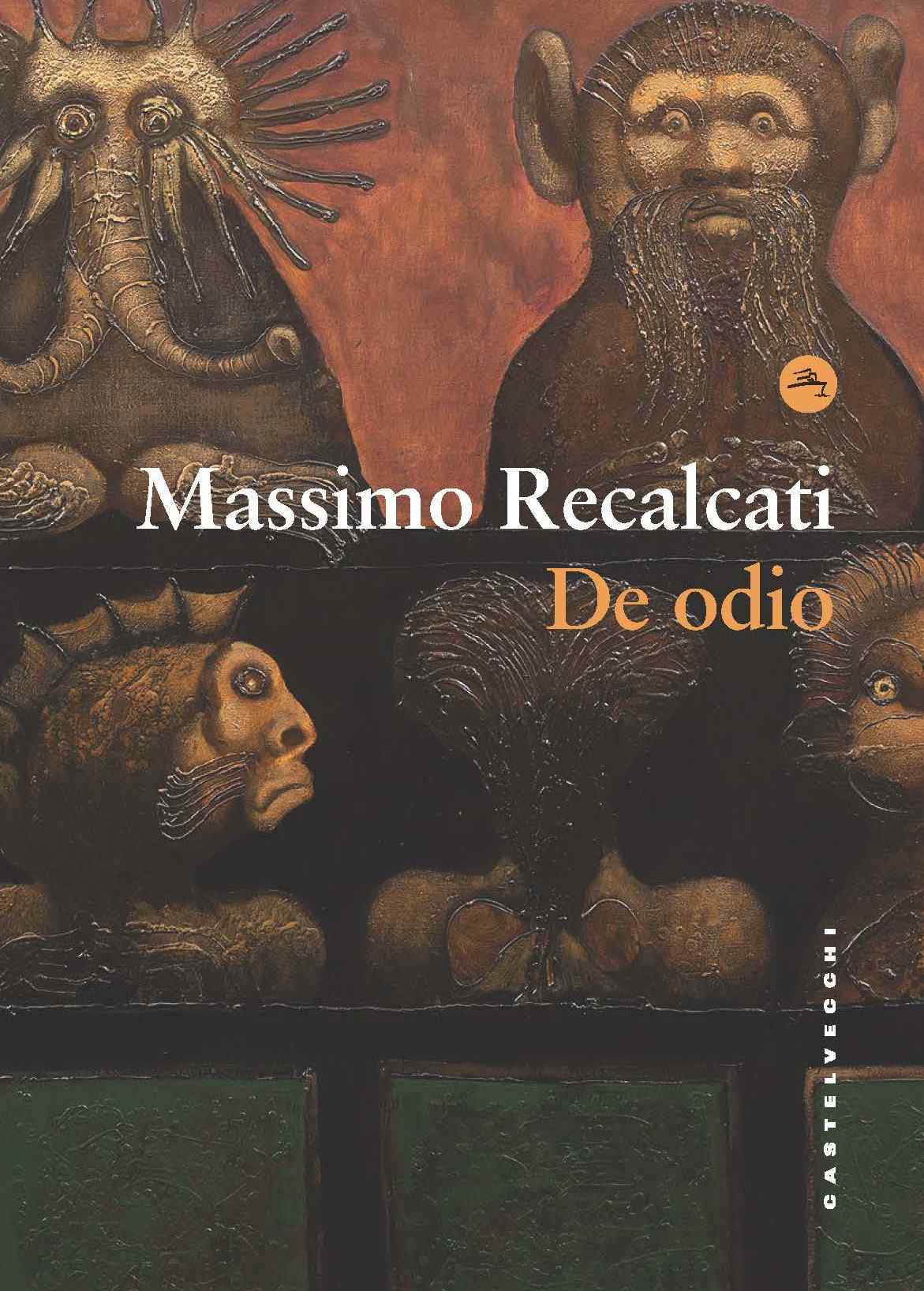
A proposito di uscite recenti, a marzo 2025 Castelvecchi ha proposto De odio, saggio dedicato a una passione propriamente umana, l’odio appunto. In tempo di guerre la sua sconcertante attualità non può non farci interrogare sulle sue più profonde radici. Se l’aggressività appare come una reazione impulsiva e disordinata a una frustrazione o a una fascinazione, per Recalcati l’odio si configura come una passione lucida che vorrebbe annientare la vita dell’Altro. In questo modo il saggista invita a guardare il lato più in ombra del desiderio: non la sua dimensione dialettica che mostra il desiderio umano come desiderio di essere desiderati dal desiderio dell’Altro, ma come spinta brutale a liberarci dall’Altro, a sottrarci al vincolo del Due che l’esistenza dell’Altro impone.
Fonte: www.illibraio.it