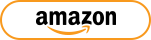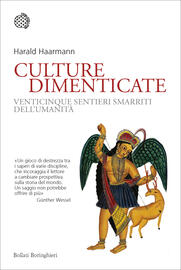Avete mai pensato al lavoro dell’interprete come a un mestiere pericoloso?Quanto è difficile tradurre frasi imbarazzanti in consessi ufficiali internazionali?Ricorderete tutti le barzellette di Berlusconi al G8 o i più recenti “shithole countries” di Trump. Anna Aslanyan ci racconta gli episodi più significativi della sua carriera e ci ricorda che per comprendere l’altro a volte […]
Avete mai pensato al lavoro dell’interprete come a un mestiere pericoloso?
Quanto è difficile tradurre frasi imbarazzanti in consessi ufficiali internazionali?
Ricorderete tutti le barzellette di Berlusconi al G8 o i più recenti “shithole countries” di Trump.
Anna Aslanyan ci racconta gli episodi più significativi della sua carriera e ci ricorda che per comprendere l’altro a volte bisogna sapersi mettere nei suoi panni. Una bella lezione di tolleranza e pluralità.
Sulla mia parola! di Anna Aslanyan
C’è chi vuole fare il traduttore di professione e chi ci arriva per caso; c’è chi dedica la vita a tradurre e chi la usa come trampolino per altri progetti. Nel mio caso si tratta di un mix di tutte le cose. Quando mi trasferii da Mosca a Londra due decenni fa, credevo che fare l’equilibrista fra russo e inglese, lavorando come traduttrice e interprete, fosse un buon modo per continuare ad allenarsi. Questo lavoro offre anche grandi possibilità di esplorare le differenze fra lingue, differenze formate da divari concettuali e presupposti culturali. È proprio all’interno di questi spazi così poco frequentati che devi prendere delle decisioni, a volte facendo affidamento solamente sulle tue capacità di giudizio, specialmente se sei tu a tenere in mano tutte le carte.
I traduttori hanno molti modi per screditarsi: stare zitti o parlare, prendere l’iniziativa o rimanere passivi, omettere un certo vocabolo oppure utilizzarlo: tutto è gravido di insidie. La fedeltà del traduttore verso la sua fonte può e deve essere messa sempre in discussione. Eppure, anche nel caso in cui non facessi alcun errore traducendo (per quanto la cosa sia difficile da immaginare, vista la natura del mestiere e i suoi vincoli), non smetterei mai di stupirmi per la fiducia che molti dei miei clienti ripongono in me.
Quando fanno la mia conoscenza – ad esempio in una cella di polizia o nella stanza dei testimoni di un tribunale – presumono che, siccome parlo la loro lingua e sono là per fornire loro assistenza, io sia dalla loro parte. Dico loro di non scambiarmi per il loro avvocato, di pensare a me come a una macchina, di dire solo quello che vogliono che i parlanti inglesi sentano dire. Rammento loro che, una volta che la procedura si è messa in moto, dovrò interpretare tutto quello che dicono, compreso «Pensa che sia meglio non dire che sono stato io a tirare il primo pugno?».E poi comincia il lavoro vero e proprio, dove gli errori sono sempre in agguato e il tempo per correggerli è poco. A volte, a posteriori, gli errori mi inducono a diffidare di me stessa. Una volta, durante un processo su un caso di abusi domestici, tradussi le parole della vittima con «era ubriaco» (la donna aveva adoperato una parola russa molto diffusa e versatile, vypivshi, che in genere non equivale a «completamente ubriaco»), avendo scartato «era alticcio» perché troppo vecchia maniera ed «era in uno stato di ebbrezza definibile di livello medio-basso, forse leggermente di più, ma decisamente non elevato» perché troppo formale e prolisso, e non avendo, chissà perché, pensato al perfettamente appropriato «aveva bevuto».
Mettere in ordine parole giuste nella giusta sequenza implica anche rispettare le sottigliezze culturali. Lo spiegano bene le diversi pratiche di asilo su cui ho lavorato in qualità di interprete. Una donna della tratta sessuale arrivata in Gran Bretagna dall’Uzbekistan continuava in aula a rivolgersi a tutti dando del tu, ty, anziché usare il formale vy. All’inizio la cosa mi infastidì, ma poi mi venne in mente che nella sua cultura il tu è un segnale di fiducia, non di impudenza o di mancanza di rispetto. Un altro parlante russo, affezionato allo stesso pronome informale, un uomo della Georgia, chiese di essere intervistato da una donna. Fui così costretta a spiegare al funzionario lo status delle donne nel Caucaso spiegando che esse sono in genere tenute in scarsa considerazione.
Per gli interpreti le emozioni possono, anche se in teoria non dovrebbero, rappresentare un ostacolo. Durante un’altra intervista per una pratica di asilo, un attivista bielorusso fu sollecitato a elencare tutti i leader dell’opposizione e i loro punti di incontro per poter provare il suo reale coinvolgimento nel movimento antigovernativo. Tradussi tutto accuratamente ma le informazioni finirono per non impressionare il funzionario poiché non coincidevano con i suoi appunti (stampati da Wikipedia, come non ho potuto evitare di notare, e non aggiornati). Per tutto il corso dell’intervista, cercavo di non pensare a ciò che sarebbe successo al giovane uomo se la sua domanda di asilo fosse stata respinta, come in effetti sembrava sempre più probabile. Tuttora non so che fine abbia fatto.
Ogni interprete ha avuto dei clienti che lo hanno fatto dannare. Una volta dovetti andare a prendere un dizionario per convincere un uomo per il quale stavo interpretando che la parola inglese feckless esiste davvero ed è sinonimo di irresponsible. E ormai non mi acciglio più quando qualcuno si ferma a metà della frase – solitamente mentre è sul punto di dire qualcosa del tipo «Mi ha letteralmente detto di levarmi dai coglioni» – per avvisarmi: «Questo non so come riuscirà a tradurlo», come se le parolacce fossero i termini più ostici da volgere in un’altra lingua.
Il senso dello humor può non essere la cosa più ovvia che un traduttore mette nel suo CV, ma se non riesce a distinguere fra ciò che è divertente e ciò che è divertente, qualcun altro finisce per ridere per ultimo.Durante una riunione con degli uomini d’affari azeri il padrone di casa raccontò una barzelletta auto-ironica nella quale si definiva «grasso». Traducendolo, non ritenni necessario ricorrere a eufemismi come «in carne» o «pienotto» e gli ospiti rimasero sconcertati dal termine che per la loro cultura era considerato sgarbato. Ma l’allocutivo più memorabile che mi sia toccato tradurre è quello adoperato in un’aula di tribunale da un testimone le cui risposte cominciavano regolarmente con le parole «Mister Judge, sir». Osservando la giudice in parrucca che presiedeva il processo mi presi la libertà di cambiare l’appellativo in «Your Honour», pensando che un po’ di diplomazia non avrebbe guastato.