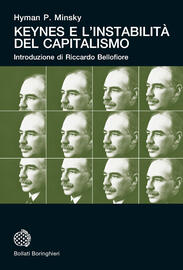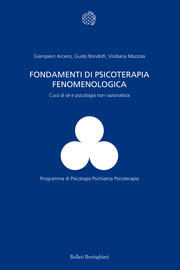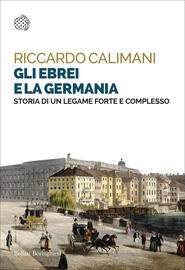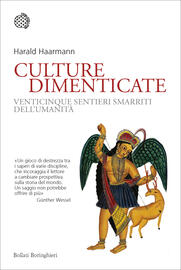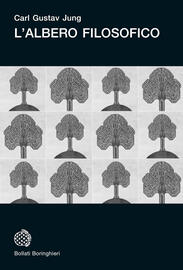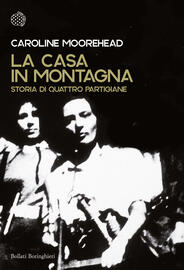Sino a oggi l’arte italiana del Ventennio non ha trovato una storiografia adeguata. Nel dopoguerra, e per decenni, si sono salvate prevalentemente figure singole e scuole ritenute – talora con palese forzatura – frondiste e marginali, retrodatandone artificiosamente il tardivo antifascismo. Così un duplice torto si è consumato ai danni di una stagione figurativa di altissimo livello: sotto attacco, negli anni trenta, da parte delle frange più retrive e autarchiche, che inveivano contro «i più rancidi prodotti del così detto “modernismo”», ossia «la malattia esterofila, la tubercolosi deformista, il gonococco astrattista e lo spirocheto novecentista», ha patito in seguito la strategia silenziante di una vulgata che la sviliva, con analoga intenzione di azzeramento, a esclusiva arte di regime. Fabio Benzi, tra i maggiori studiosi di quel periodo artistico, si libera dei clichés più usurati e mistificatori e in un saggio di svolta riscrive daccapo l’intera vicenda. Nel quadro che ricompone davanti a noi, corredato di un’antologia di testi teorici e di una ricca iconografia, tutto acquista nitore, protagonisti e comprimari, opere e idee, mostre e manifesti programmatici, movimenti e poetiche di gruppo, mentre risalta la loro statura internazionale e viene in luce la capacità della politica culturale fascista di metabolizzare avanguardie in lotta reciproca. I cultori di un realismo didascalico o di una «anemica» pittura da cavalletto vennero oscurati dal giganteggiare di espressionismo, astrattismo, futurismo nelle sue diverse propaggini, «macchinista» e biomorfa. E fascisti dichiarati furono gli artisti di spicco, dal Sironi muralista a Prampolini a Marinetti, da Severini a Balla a Martini. Sostenuti a loro volta dai vertici del regime, che per bocca di Bottai rinunciò a «decaloghi» e «massimari» estetici. A creare un’«arte fascista» sarebbero bastati «artisti autentici e schietti».