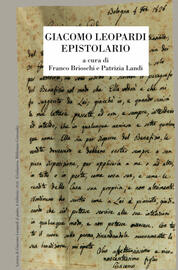Nel nuovo libro di Francesca Serra a confronto due miti nati nella seconda metà dell’Ottocento: Helena Blavatsky e il continente scomparso di Lemuria, presunta culla dell’umanità e luogo della più antica purezza perduta...
Francesca Serra insegna Letteratura italiana all’Università di Ginevra. L’autrice delle Brave ragazze non leggono romanzi, che ci ha divertiti e istruiti con la sua critica letteraria priva di pedanteria, mette a confronto due miti nati nella seconda metà dell’Ottocento: Helena Blavatsky e il continente scomparso di Lemuria, presunta culla dell’umanità e luogo della più antica purezza perduta.
Nel romanzo La grande Blavatsky (Bollati Boringhieri) Serra tenta l’impossibile: dimostrare che le due leggende non solo si incontrano, ma si fondono nella Storia di un secolo, continuando a sopravvivere per tutto il Novecento e a deliziare i seguaci delle dottrine occulte, dei culti sincretici e delle religioni orientali divulgate ai profani. Per raccontare tale vicenda, l’autrice ci trascina dentro un labirinto di verità storiche e di ipotesi, azzardate quanto plausibili, seguendo il filo della sua immaginazione solidamente ancorata ai fatti.
Sarà vero, per esempio, che Helena Blavatsky, indossata la camicia rossa dei garibaldini, viene ferita a Mentana e resta sepolta sotto un mucchio di cadaveri per poi riemergere come niente fosse? Oppure che la nostra eroina, sapendo che il confine del Tibet può essere attraversato solo dentro una cassa da morto, si autosospenda dallo stato vitale e riesca a scoprirne i segreti? Infine cosa hanno in comune i baffi di Hitler, la barba di Garibaldi e lo yoga di Marilyn Monroe? E cosa c’entra Lemuria? Perché il mitico uccello Dodo è scomparso in quel modo misterioso?
Per gentile concessione dell’editore, su ilLibraio.it proponiamo un estratto
Parte prima
Il giallo del Dodo scomparso
Londra 1831-1891
L’influenza del 1891 Da molti anni Helena Blavatsky viveva dentro un calesse a due ruote che le faceva anche da letto. Una speciale imbottitura di lana era stata cucita all’interno dell’abitacolo, in modo da rincalzarla lasciando fuori ogni spiffero. Un tempo la carrozzella serviva a passeggiare la domenica dentro Regent’s Park, attaccata a un cavallo di piccola taglia. In caso di pioggia il mantice si chiudeva automaticamente, proteggendo il passeggero dalla testa ai piedi. Poi il calesse era diventato una specie di risciò, con al posto dei cavalli uno o due uomini che trasportavano Helena dappertutto.
Al fianco aveva sempre i suoi angeli custodi. Una coppia di giovani fratelli avvocati, tra i più brillanti del paese, pronti a servirla e riverirla come una dea. La carnagione ambrata, perfettamente liscia anche in quell’età che stropiccia ogni cosa, le dava l’aria di un totem. Mentre gli occhi chiarissimi sembrava che avessero il potere di rendere immateriale il mondo intero. S’infilavano sotto i lugubri panciotti vittoriani dei suoi ragazzi e li spogliavano con la forza del pensiero di vestiti e mutande, lanciandoli nudi come puledri alla testa del calesse che la portava a spasso.
Viveva al n. 19 della Avenue Road, nel quartiere St. John’s Wood di Londra. Qui morì l’8 maggio 1891, vittima di un’epidemia d’influenza che si portò via altri duemila abitanti della città. Molti dei quali vecchi e bambini.

Quando il respiro le si fermò in gola, dopo una serie spossante di colpi di tosse che le impedirono di finire l’ultima sigaretta, gli occhi le uscirono quasi dalle orbite, come per un fulmine che l’avesse colpita senza chiederle il permesso. Qualcuno disse che erano diventati del tono squallido della palude. Altri che si erano semplicemente svuotati di ogni colore. Di certo non si moriva allegri di quella roba lì: una maligna bestiola che nei giorni più tiepidi della primavera iniziò a scorrazzare per le strade della città, accucciandosi sotto la pelle di grandi e piccini fino a spezzargli le ossa.
Intanto il grande anello al mignolo sinistro della zia Nadia, che Helena le aveva portato un quarto di secolo prima dall’India, aveva cambiato colore. L’agata perse all’improvviso quella sua tipica lucentezza giallastra, appena incupita da un ciuffo di muschio al centro, per diventare quasi nera.
La notte tra il 7 e l’8 maggio il muro della camera degli ospiti al piano di sopra venne giù con uno strepito spaventoso, mentre il pianoforte in salotto suonò allegramente fino all’alba. Nonostante fosse chiuso e nessuno lo stesse toccando.
(C) 2016 Bollati Boringhieri editore, Torino
(continua in libreria…)
Fonte: www.illibraio.it