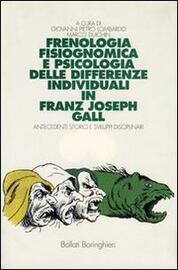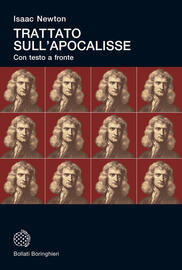"Il design è come il sale: preso nella giusta dose, dà sapore e significato alle cose, le rende gradevoli e desiderabili. Proprio come il sale, un pizzico di design sta bene quasi dappertutto". Francesco Trabucco, autorità internazionale in materia, in un saggio spiega come l'alleanza tra la forma e il tempo di cui diventa espressione è insieme ragion d’essere e principio regolatore del design... - Su ilLibraio.it un capitolo
Se ci mostrassero una serie di immagini di prodotti industriali – automobili, elettrodomestici, computer, cellulari – e ci chiedessero di metterle in sequenza cronologica, è probabile che non sbaglieremmo, anche se ignorassimo i requisiti tecnici e prestazionali di quegli oggetti. A guidarci basterebbe la loro forma, segnale inequivocabile di maggiore o minore attualità. L’alleanza tra la forma e il tempo di cui diventa espressione è insieme ragion d’essere e principio regolatore del design. Discendente dalla nobile schiatta dell’architettura e dalla meno titolata arte manifatturiera, il design ha dato corso alla sua natura di figlio ribelle,febbrilmente votato all’innovazione, tra guizzi autoriali e consapevolezza dei vincoli tecno-economici posti alla sua peripezia intellettuale, e sempre in fuga dall’etichettatura metodologica e disciplinare.
L’architetto Francesco Trabucco è un’autorità internazionale in materia di design. Professore ordinario di Disegno industriale al Politecnico di Milano, presso cui dirige i master Design Engineering and Innovation e Design for Architecture, coordina il dottorato di ricerca in Design. Ha vinto numerosi concorsi di architettura e premi internazionali di design, tra cui il Compasso d’Oro, il Gute Form e il Bio.
Ora arriva in libreria il suo nuovo saggio, Design, in cui, dal carattere sfuggente del design, riesce a ricavare il suo identikit.
Su ilLibraio.it un estratto dal volume
(per gentile concessione di Bollati Boringhieri)
Il design è come il sale: preso nella giusta dose, dà sapore e significato alle cose, le rende gradevoli e desiderabili. Proprio come il sale, un pizzico di design sta bene quasi dappertutto, e questo spiega perché il design sia così diffuso, anzi pervasivo e trasversale: design degli oggetti e delle macchine per produrre quegli oggetti, design delle relazioni e delle comunicazioni, design degli ambienti e delle interazioni, design delle strategie e dei servizi. Anche il design, come il sale, va usato però con parsimonia e accortezza: troppo design forse non fa male, ma annoia; troppo poco lascia insoddisfatti, tanto che ci si domanda se ci sia oppure no.
Il design si lega indissolubilmente a ciò che pervade, tanto da essere indistinguibile da esso. Il suo contributo non può essere sottratto dal tutto di cui fa parte: è irreversibile. Il design agisce come una sorta di lievito espressivo della modernità. Molte cose e molti processi risultano modificati dalla sua azione, ma tali modificazioni non sono esattamente definibili. A differenza delle discipline tecniche o scientifiche, i cui risultati sono esprimibili con un algoritmo, il design produce soluzioni aleatorie, imprecise, soluzioni che gli studiosi anglosassoni talvolta chiamano wicked problems. Il design è un’attitudine espressiva che include tuttavia esperienze di ricerca, ossia attività capaci di produrre elementi conoscitivi; infatti il design agisce sulla forma delle cose e quindi su aspetti non marginali della nostra conoscenza del mondo.
Quasi tutto ciò che conosciamo delle antiche civiltà deriva dallo studio degli oggetti sopravvissuti, inclusi estensivamente gli edifici. Nel presente osserviamo le case, le insegne, i mezzi di trasporto, gli abiti, le merci, e apprendiamo sincreticamente dalla loro forma enormi quantità di informazioni relative a luoghi, persone, culture, tecnologie, linguaggi. La tecnologia digitale, certamente la più densa di informazioni tra quelle sperimentate finora dall’umanità, opera in gran parte attraverso l’elaborazione di immagini. Inoltre la nostra esperienza del mondo è sempre più virtuale: l’infinito sistema delle comunicazioni di massa che abita il nostro quotidiano, dalla pubblicità al web, è costituito di immagini, immagini di forme, immagini bi- e tridimensionali, ferme e in movimento. Nella costruzione di tali immagini spesso è riconoscibile il contributo di un designer che attiva processi di innovazione estetica, di linguaggio, d’uso e di senso, producendo negli utenti continue e sempre nuove esperienze.
Infine, di design si è scritto e parlato molto, in riviste di moda e di attualità, giornali economici e di marketing, riviste d’arte e di cultura, ma anche saggistica scientifica ed economica, mostre, talk-show, spettacoli teatrali, film, pubblicità e incontri mondani. Ma in questi tempi difficili è più che naturale che anche il design mostri segni di malessere, non solo perché è in crisi il sistema manifatturiero del nostro Paese, ma anche perché la grande espansione orizzontale dei possibili campi di applicazione della pratica del design, in cui si mescolano saperi multiformi, rischia di mettere in crisi la consistenza stessa della disciplina.
D’altra parte, è facile constatare che stiamo diventando una società diffusamente progettante, dove il design tende a diventare un mestiere, una pratica di massa. Il design allargato, diffuso, massificato e massmediatico, insieme alla presenza pervasiva delle tecnologie digitali, ha reso gratifi cante e accessibile la pratica del progetto: non solo si sono aperti sconfinati orizzonti nelle scelte di acquisto di beni e servizi offerti sul mercato globale, ma relativamente alle proprie possibilità e competenze si può progettare la propria casa, la propria immagine, le proprie relazioni sociali, sia nel mondo fisico sia, e forse soprattutto, nello sconfinato paesaggio planetario dei social media. Sta accadendo qualcosa di simile a ciò che è successo in questi anni alle arti figurative, al cinema, al teatro, alla musica e alla letteratura: chiunque possieda uno smartphone è tecnicamente in grado di produrre da sé un’opera d’arte e di metterla in rete, insomma di pubblicare il proprio lavoro, e ciò a prescindere dal giudizio di valore su quelle espressioni artistiche. Chiunque possieda un computer e abbia delle nozioni di modellazione tridimensionale può progettare e produrre oggetti tramite additive manufacturing: tecnologie alla portata di tutti che stanno esplorando con crescente successo nuovi e interessanti spazi di progettualità.
Tuttavia l’onnipresenza del design sulla scena della contemporaneità rischia di renderlo evanescente ed è, almeno in parte, alla base della sua interpretazione tendenzialmente frivola, appiattita ed esornativa come «aggiunta» ai prodotti industriali. È quindi del tutto comprensibile la tentazione, da parte di molti intellettuali, di porsi al di fuori di un design che appare invasivo, contraddittorio e comunque troppo mercificato, alla ricerca ansiosa di visibilità prima che di contenuto, di successo prima che di valore, tanto che talvolta sembra adottare atteggiamenti di stampo dadaista per sopravvivere nell’affollato palinsesto della comunicazione globale.
Va considerato poi come la drammatica congiuntura macroeconomica che in questi anni ha impoverito anche il nostro Paese coincida con un cambiamento radicale degli equilibri economici del mondo, e come ciò implichi la riscrittura di alcuni parametri attraverso i quali siamo abituati a misurarlo. Forse non si può più contare su una espansione dei consumi capace di garantire lo sviluppo costante delle economie. Cambiano le tipologie dei consumi insieme ai significati di cui sono portatori, cambia la cultura del consumo perché si confronta non solo con una inedita sobrietà, ma con altre aspirazioni e logiche, insieme a una nuova idea di qualità della vita, a nuove concezioni del limite, della conservazione e tutela dell’ambiente, dell’inclusione sociale. Cambiamenti che hanno un impatto sulla disciplina e la pratica del design. A molti può sembrare fuori luogo, se non inopportuno, parlare ancora di un design legato al gusto, al lusso, all’eleganza. Tuttavia Paesi a economia emergente investono sul design considerandolo uno strumento per aggredire i mercati dei Paesi ricchi; mentre noi, che sul design non abbiamo investito pressoché nulla, continuiamo a ritenerlo una risorsa strategica per salvare le nostre industrie.
Quali industrie? E quale design? Come collocarlo più seriamente in questo quadro? Vi è un nuovo ruolo per il design italiano? Il nostro Paese chiacchierone e litigioso, dove la res publica, incluse le risorse paesaggistico-ambientali e il patrimonio artistico, è tuttora res nullius, ha davvero qualche ragione per rivendicare quella predicata capacità naturale di produrre bellezza e qualità del vivere, ipotizzati dal nostro design così come dalla nostra moda e dal nostro cibo?
Forse la capacità è diventata solo presunzione, perché l’Italia non ha investito nulla in design, nulla in ricerca, nulla in promozione, nulla in sostegno alle imprese del design. Anche la Comunità Europea, che pochi anni fa inseriva il design tra le priorità comunitarie, riconoscendone il grande contributo all’economia dei Paesi che adottano politiche di sostegno a tali attività e i vantaggi di natura macroeconomica per la Comunità stessa, non risulta che finora abbia investito granché.
La prospettiva sarebbe disperante, se non fosse per quei giovani designer, molto hungry e molto foolish (Steve Jobs) che stanno scoprendo una diffusa volontà di progetto in discipline, tecnologie e competenze diverse, ma unificata dalla volontà di arricchire di valori estetici e di qualità d’uso l’esperienza della quotidianità, e stanno cercando il senso di quel fare come atto essenzialmente intellettuale, via estetica per vivere il presente. Sostenere la loro ricerca di futuro vale l’impegno di parlare ancora di design.
Fonte: www.illibraio.it