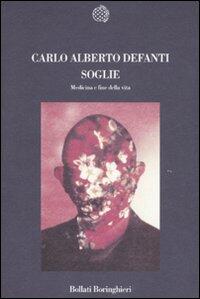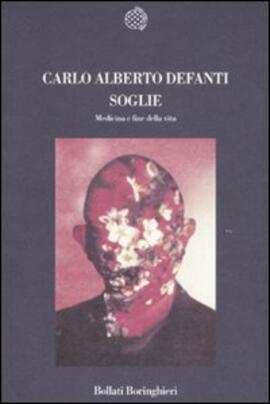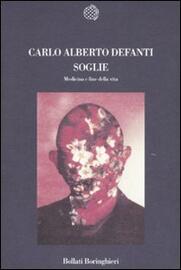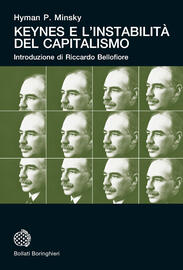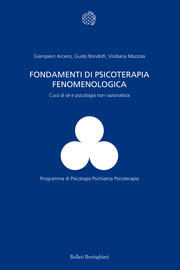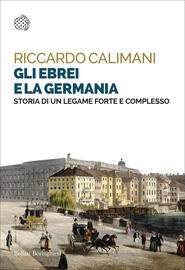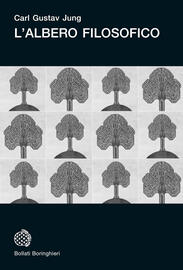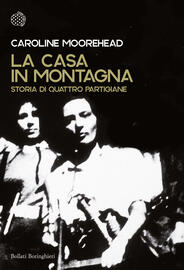Rispetto a un passato da cui ci distanziano solo pochi decenni, la soglia estrema degli umani ha perso la sua residua inquestionabilità ed è diventata sempre più oggetto di definizione stipulativa. Adottare l’uno o l’altro dei tre criteri tuttora controversi – morte cardiaca, morte cerebrale, morte corticale – sortisce evidenti conseguenze di rilevanza sociale, oltre a sollevare dilemmi di natura bioetica, dalla liceità delle misure di sostegno vitale agli usi del cadavere. Se per secoli ci si è attenuti al principio del cor ultimum moriens, gli sviluppi recenti della ricerca scientifica hanno portato a ritenere segno di vita non il battito cardiaco, bensì la persistenza delle funzioni cerebrali o la conservazione dell’identità personale. Tecniche rianimative e trapiantologia sembrano alimentare oggi un paradosso: si protrae artificialmente la vita dei pazienti e, al contempo, si ha la necessità di anticipare la dichiarazione di morte, per espiantare organi non deteriorati. L’antica paura della morte apparente, ossessione della medicina e incubo dei morenti, si è capovolta nel timore che corpi morti vengano considerati in vita.
Ed è proprio la morte cerebrale, presente nella maggior parte delle attuali legislazioni occidentali, compresa la nostra, a destare perplessità anche in chi, come il neurologo e bioeticista Carlo Alberto Defanti, ne era sostenitore e continua a giudicare irrinunciabile la pratica del trapianto che nel criterio cerebrale – in quanto prognosi di morte imminente del donatore, futuro cadavere a cuore battente – ha trovato sinora fondamento. Gli aspetti che rendono problematica questa «morte prima della morte» e coinvolgono le condizioni liminari di non-vita, prima fra tutte lo stato vegetativo permanente, sono affrontati da Defanti in un saggio illuminante, che recepisce le istanze più avanzate del dibattito internazionale in bioetica, indica i rischi della soggezione medica all’imperativo tecnologico e si sofferma sui casi più recenti di negazione della dignità del morire.