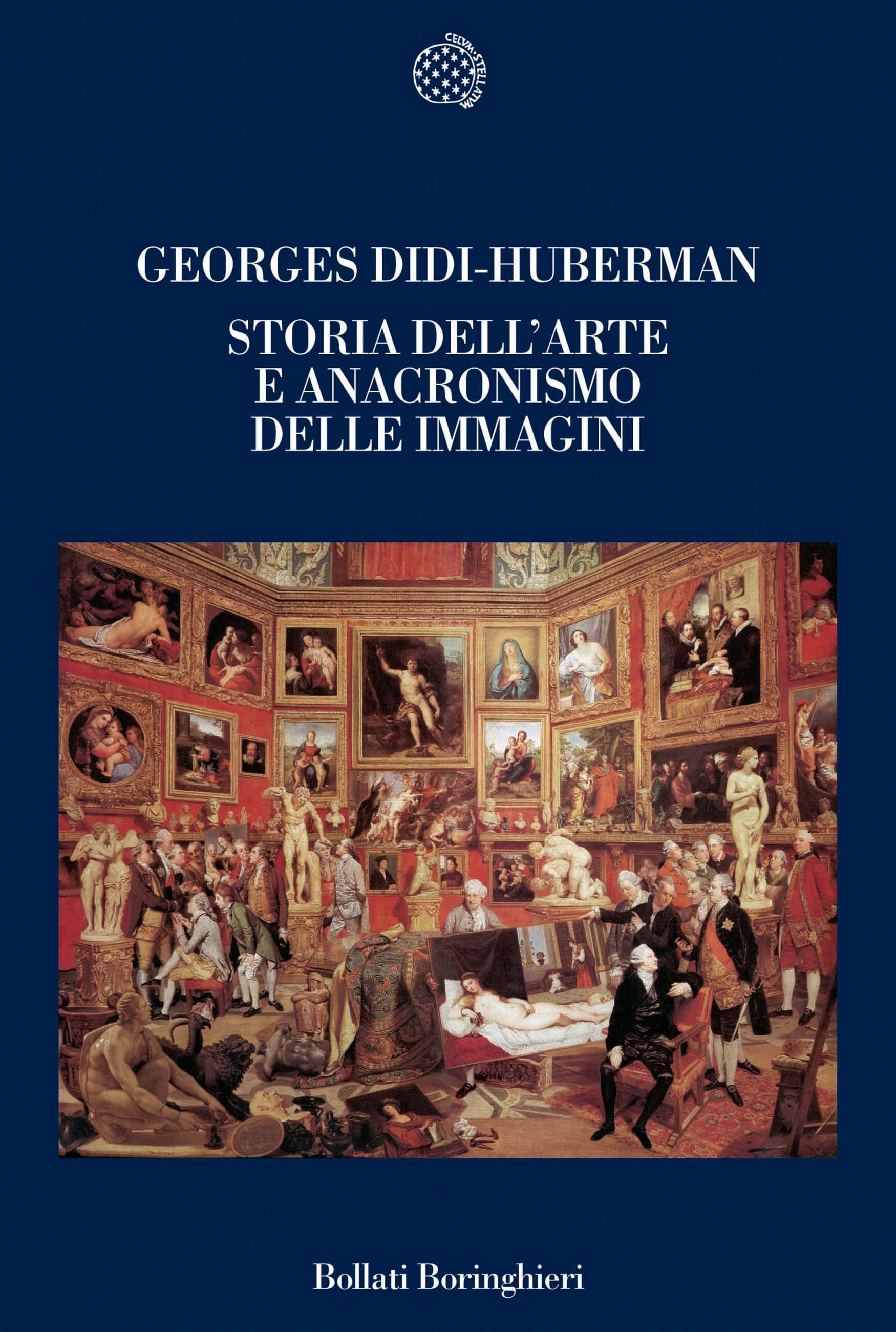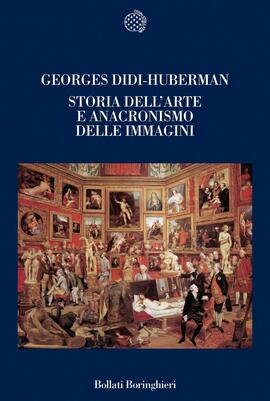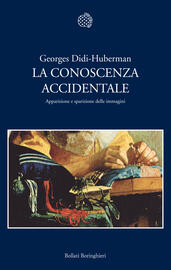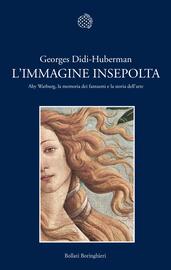Intrusione di un’epoca in un’altra, proiezione sul passato di categorie che non gli appartengono, crollo della distanza tra gli oggetti o gli eventi remoti e i loro esegeti: l’anacronismo è malfamato, reca impresso uno stigma che lo bandisce da ogni storiografia rispettabile, compresa la storia dell’arte. Ma il tabù di quello che viene ritenuto un grossolano sviamento dai canoni disciplinari è rovesciato da Didi-Huberman in una prospettiva di elezione, in cui il presunto falsario temporale si riabilita a paradigma vitale dell’interrogazione storica. Solo attraverso l’anacronismo è possibile rompere la dinamica chiusa della cronologia e accostare le immagini senza ridurle a reperti di un corpus monumentale, a puri feticci o fonti documentali. Perché – lo scrissero negli anni venti e trenta del secolo scorso Walter Benjamin e Carl Einstein, accomunati dall’ostracismo accademico e da un destino tragico – occorre pensare insieme tempo e immagine, anzi collocare l’immagine al centro della riflessione sul tempo. Grazie anche a loro, oggi una archeologia critica dei modelli di tempo appare inscindibile da una critica della rappresentazione. Quale tempo ci sta allora di fronte nell’immagine? Un tempo plurale, un montaggio di temporalità sfasate, di ritmi eterogenei, come accade in un affresco del Beato Angelico, dove un pensiero mistico del V secolo si incastona in una cornice già rinascimentale. La storia dell’arte non può che esercitarsi sul temporalmente impuro, modificando lo schema epistemico della storia stessa e riconfigurando presente e passato. «L’immagine – insegna Didi-Huberman – ha spesso più memoria e più avvenire di colui che la guarda».